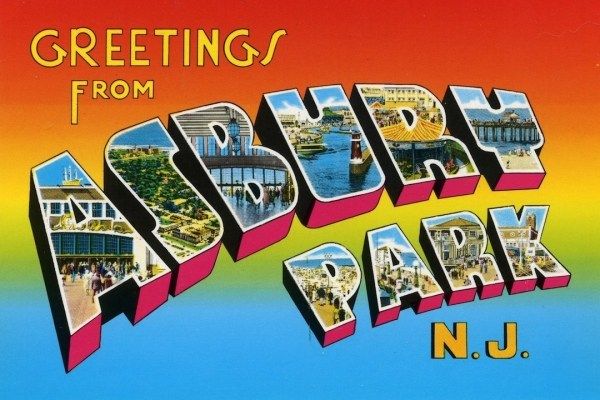
Con Bruce Springsteen ho girato l’america in lungo e in largo, bastava un “play” e dalla sua musica si snodava sempre una strada che arrivava lontano, liberava, e conduceva al sogno. Ho iniziato intorno ai 7/8 anni ad ascoltarlo, quando “Born in the USA” era in testa alle classifiche e le stelle della bandiera americana e la sua t-shirt bianca erano la mia America fatta in casa. Il New Jersey era un luogo magico nel mio immaginario, dove succedevano le cose magnifiche che Bruce cantava in quelle canzoni dall’energia pulsante e carismatica. Quello che raccontava era qualcosa di famigliare, il mio quotidiano in versione oltreoceno, amplificato, espanso, magnificato. Il mio mondo di allora, per me l’unico possibile ed immaginabile, diventava vero nella sua musica, e questo mi confermava che la mia vita era bella, si poteva raccontare, condividere, e ballare.

I testi li trovavo su “TV, Sorrisi&Canzoni” con la traduzione affianco, ma non era come interrogare Google, ti beccavi un testo che era frutto del caso e la comprensione del resto della canzoni era lasciata all’eventualità, alla parola che riuscivo a carpire coll’inglese ancora migliorabile e agli strumenti che coprivano la voce. A scuola frequentavo il tempo pieno, tre volte alla settimana lezione di Inglese dove andavo perchè volevo cantare, e anche perchè ogni tanto potevo chiedere alla maestra che significa. Non so se fosse frutto del caso, un fatto meramente statistico o se, semplicemente, il cuore di chi ama capisce meglio della testa, fatto sta che le parole che sentivo nitidamente erano sempre “highway”, “car”, “Buick”, “Cadillac”, “Driving”, “Garage”, “Hometown”.
In edicola trovai un libricino rilegato con la vita di Bruce Springsteen corredato di foto a colori. Ricordo ancora perfettamente le parole con cui raccontava che sentendo suo padre alzarsi la mattina presto per andare a lavoro in fabbrica, iniziò a crescere dentro di sè il sogno di una vita migliore. Leggendo quelle parole venni a contatto per la prima volta, e inconsapevolmente, col messaggio universale di cui è portatore la letteratura. Mi emozionai, allo stesso modo in cui i bambini si emozionano quando vedono le immagini del proprio paese in TV (quelli di città ci sono abituati, pensavo). Ma quello che che avevo letto era ben più profondo della sensazione di sentirsi parte della storia quando in TV aspetti che il TG nazionale mandi in onda le immagini del Giro D’Italia che ti passa sotto casa e, per un attimo, la strada in cui vivi è in prima pagina.

CANADA – JULY 24: Photo of Bruce SPRINGSTEEN; Bruce Springsteen performing on stage (Photo by Ebet Roberts/Redferns)
Le canzoni di Bruce legittimavano la mia quotidianità e sdoganavano quei sogni che sentivo dentro e non sapevo modellare, perchè io avevo quello stesso desiderio ma non ancora decodificato a parole. Anche io sentivo mio padre che metteva in moto la macchina per uscire, al mattino. Mi svegliavo prestissimo e, avvolta nel buio della mia camera, seguivo la giornata che si avviava raccontata dai rumori: dalla frequenza della lametta picchiettata sul lavandino mentre mio padre canticchiava, dalle pentole in cucina e mia madre già in ritardo, poi il rumore della carta stagnola avvolgeva il pasto seguito dalla porta di casa che si chiudeva e poi dal portone quando mio padre era arrivato in fondo alle scale. La macchina in moto era il giorno che partiva, il primo rumore definito che sentivo dalla strada. Il mio mondo era fatto di adulti che si svegliavano presto e che andavano a lavoro quando fuori era ancora buio, della responsabilità di dovermi gestire e di dovere stare dietro anche a mio fratello più piccolo perchè i miei non c’erano. Non mi ero mai neanche interrogata se come stessi crescendo fosse giusto, era quello il solo modo in cui le cose potevano essere. Quando uscivo da scuola avevo in tasca i soldi contati che mi aveva dato mia madre per comprare il pane e, prima di tornare per pranzo, passavo al negozio. Trovavo apparecchiato per uno perchè i miei genitori non tornavano a pranzo, il pasto preparato al mattino a era freddo a quell’ora.
Non ero triste, il mio quotidiano era rassicurante ed avvolgente a suo modo. Seppur microscopico, nel mio orizzonte c’era spazio sufficiente per farci entrare anche i sogni. Le persone c’erano con la loro assenza: mio padre col rumore della macchina e della stagnola del pasto, mia mamma con la tavola apparecchiata per me, mio fratello coi suoi giochi mi avrebbe raggiunta per intrufolarsi con noi grandi. Tutto quello che c’era intorno a casa era piccolo ed espandibile con la fantasia: il campo da calcio, il bosco, il mare al di la’ della strada. Nelle canzoni di Bruce c’era il baseball perchè lui era nato in America, ma anche la sua strada era un territorio da presidiare, pieno di insidie da cui difendersi, ricco di scoperte. Quando ascoltavo “My Hometown”, mi sembrava di sentire tutta la poesia della mia esistenza cantata come se stessi conducendo la vita più intensa che si potesse immaginare, in quelle parole il mio mondo si espandeva e la 127 a gas di mio padre diventava una Buick:
“Avevo otto anni e correvo
con 10 centesimi in mano
alla fermata dell’autobus per comprare il giornale
a mio padre.
Sedevo sulle sue ginocchia nella vecchia Buick
giravo il volante mentre attraversavamo la citta’.
Lui mi scompigliava i capelli e diceva:
“Figliuolo, guardati attorno,
questa e’ la tua città.” (vedi note)
Lo stereo da cui l’ascoltavo era un compatto, poco potente con due piccole casse e la doppia cassetta, di una marca scadente, che mio padre aveva comprato da un ambulante che passava nell’officina dove lavorava. Niente di tutto questo mi impediva di riempire il regno della mia fantasia di immagini dense e cariche di colore, dove lo sterzo della Buick si sostituiva a quello della 127. Ero orgogliosa della mia realtà e mi ripetevo “questa è la tua città”: il campo da calcio, il bosco, il mare ad di la’ della strada erano il mio spazio infinito, favoloso.
“Born in the USA” ero riuscita addirittura a comprarmelo originale. La t-shirt bianca divenne una seconda pelle e il cappellino con la visiera non serviva più solo a riparare dal sole: combinati insieme erano il segno di un’identità ed io, ancora acerba ed ingenua, iniziavo a sperimentare chi volessi essere attraverso la musica. Le canzoni erano il veicolo potente di un modo di fare poesia immediato e diretto. La musica era il mezzo attraverso il quale portare l’intimità fuori dal diario segreto senza vergognarsene: la scrivevamo sugli zaini, sui diari degli amici, la cantavamo al mare nelle lunghe giornate estive tutti raccolti attorno a chi strimpellava la chitarra. I tre colpi iniziali di “No surrender”, seguiti una scarica travolgente di batteria, stimolavano la prima tornata di endorfine, mentre mi allacciavo le scarpe per scendere a giocare a calcio al campetto sotto casa, partite che duravano pomeriggi interi e continuavano, anche dopo che il sole capitolava dietro le colline e la luce ancora piena illuminava ogni cosa senza ombre. Quando tornavo, le luci dei lampioni erano fioche e la strada buia intuibile nell’oscurità. Sporca e polverosa, con la palla sotto braccio e le mani gonfie per reazione alla polvere, non mi sono mai sentita così tanto viva.
Respiravo a pieni polmoni l’inconfondibile umidità della sera dei paesi di mare, e l’odore di pini e di pitosfori si scioglieva insieme in un solo aroma, speciale. Bruce raccontava, in quel libretto preso nella mia edicola, che ad una certa ora del giorno si spandeva nell’aria l’odore del caffè tostato nella fabbrica del Nescafè di Freehold. A Silvi c’era la Saila, che diffondeva nell’aria l’odore di liquirizia. Tra l’odore della liquirizia, dei pitosfori, dei pini, del mare, della polvere della strada di casa, mi trascinavo indietro stanca e viva, invisibile. Dancing in the dark.
Note: Trad. Da “Come un Killer sotto il sole”, di Leonardo Colombati, Mondadori
Maria Rita Carota



What do you think?